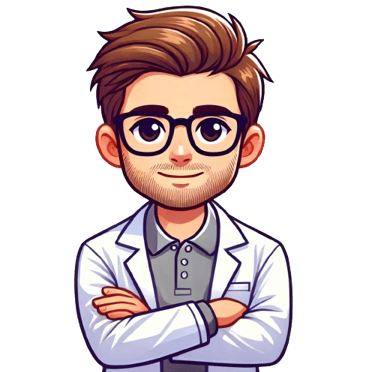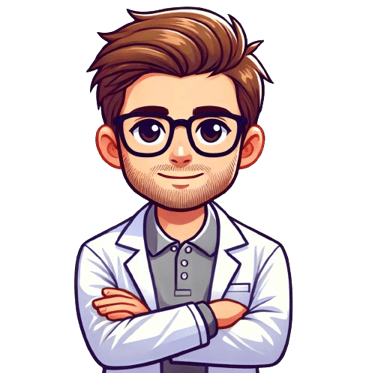Probiotici e gastroenterite nei bambini: quando servono davvero
I probiotici possono aiutare a ridurre la durata della diarrea, ma solo alcuni ceppi hanno dimostrato efficacia. Ecco cosa dicono le evidenze e come usarli correttamente.
Piercarlo
11/1/202533 min read
Probiotici e gastroenterite nei bambini: funzionano davvero?
La gastroenterite acuta è tra le malattie più comuni nei bambini: diarrea, vomito e febbre mettono spesso in crisi tutta la famiglia.
La cura principale rimane sempre la reidratazione orale e una rialimentazione precoce, ma molti genitori chiedono se aggiungere un probiotico possa aiutare a guarire prima.
Vediamo cosa dicono gli studi.
Cosa sono e come agiscono
I probiotici sono microorganismi “buoni” (come Lactobacillus o Saccharomyces boulardii) che aiutano a riequilibrare la flora intestinale alterata durante un’infezione.
Agiscono in diversi modi:
impediscono ai batteri patogeni di attaccarsi all’intestino,
producono sostanze che li contrastano,
modulano l’infiammazione,
aiutano la mucosa intestinale a ripararsi più in fretta.
Nei bambini sani sono considerati sicuri, con effetti collaterali rari e lievi (gonfiore, borborigmi).
💧 Cosa dicono le evidenze
Gli studi e le meta-analisi mostrano che i probiotici possono:
ridurre di circa 1 giorno la durata della diarrea,
attenuare l’intensità dei sintomi (meno scariche, recupero più rapido).
Non sono però una cura miracolosa: il beneficio è modesto ma reale, e dipende dal ceppo usato e da quando si inizia la somministrazione (prima è meglio).
🧫 I ceppi che funzionano davvero
Secondo le linee guida ESPGHAN (2023), i ceppi con prove più solide sono:
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) → 10 miliardi/die per 5-7 giorni
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 → 250–500 mg/die
Lactobacillus reuteri DSM 17938 → 1–4 × 10⁸ UFC/die
Altri fermenti o mix “generici” non hanno dimostrato lo stesso effetto: in questo campo non vale il “uno vale l’altro”.
💊 Quando e come usarli
Iniziarli entro 48-72 ore dall’inizio della diarrea.
Continuare almeno 5 giorni.
Possono essere dati anche insieme alla soluzione reidratante orale.
Se il bambino prende antibiotici, S. boulardii o LGG aiutano a prevenire la diarrea da antibiotico.
⚖️ Cosa dicono le linee guida
Europa (ESPGHAN): probiotici raccomandati come supporto, non come obbligo.
USA (AGA/AAP): più cauti, non li consigliano di routine.
OMS: riconosce un possibile beneficio ma non li include tra i trattamenti essenziali.
🧠 In sintesi
✅ Possono accorciare leggermente la durata della diarrea.
❌ Non sostituiscono reidratazione e alimentazione.
🧬 Funzionano solo alcuni ceppi specifici.
💬 Se il pediatra li consiglia, è un aiuto in più — non una necessità assoluta.
Conclusione:
I probiotici non fanno miracoli, ma possono dare una mano.
Usati nel modo giusto, aiutano l’intestino a rimettersi in equilibrio più rapidamente — rendendo la gastroenterite un po’ meno lunga e più sopportabile per tutti.
Hai appena letto un riassunto del papiro che c'è qui sotto, se hai voglia di approfondire...buona lettura!!
Probiotici nella gastroenterite acuta pediatrica: efficacia e utilizzo
La gastroenterite acuta è una delle patologie pediatriche più comuni, caratterizzata da diarrea e spesso vomito e febbre. Il trattamento principale rimane la reidratazione orale e una rapida rialimentazione. Negli ultimi anni si è discusso dell’utilizzo dei probiotici come terapia aggiuntiva per ridurre la durata e la severità della diarrea nei bambini. In questo approfondimento analizziamo le evidenze scientifiche sull’uso dei probiotici nella gastroenterite acuta infantile, quali ceppi hanno dimostrato efficacia (e come agiscono), nonché le linee guida ufficiali e le indicazioni pratiche su formulazioni, dosaggi e durata del trattamento. Inoltre, considereremo l’uso dei probiotici nelle diverse cause di diarrea acuta, incluse le forme virali, batteriche e le diarree associate ad antibiotici.
Cosa sono i probiotici e come funzionano
Secondo la definizione FAO/OMS e dell’International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, i probiotici sono “microrganismi vivi che, somministrati in adeguata quantità, conferiscono un beneficio di salute all’ospite” . Si tratta perlopiù di batteri benefici normalmente presenti nell’intestino umano (soprattutto Lattobacilli e Bifidobatteri), oltre a lieviti come Saccharomyces boulardii, formulati in prodotti sotto forma di integratori o alimenti fermentati. In ambito italiano, i probiotici sono spesso chiamati impropriamente “fermenti lattici”, termine colloquiale che però andrebbe riservato ai batteri lattici impiegati nelle fermentazioni alimentari .
I probiotici esercitano vari effetti benefici nel tratto gastrointestinale, anche se molti meccanismi non sono ancora completamente noti. In generale, competono con i patogeni intestinali e aiutano a ripristinare l’equilibrio del microbiota (“eubiosi”). Alcune azioni chiave dei ceppi efficaci includono:
• Adesione alla mucosa intestinale: certi probiotici riescono ad aderire all’epitelio intestinale più saldamente dei patogeni, ostacolandone l’attacco. Ad esempio Lacticaseibacillus rhamnosus GG (LGG) e Saccharomyces boulardii mostrano una forte capacità di adesione alla mucosa . Ciò crea una barriera biologica che impedisce ai microbi dannosi di colonizzare e danneggiare l’intestino.
• Competizione nutritiva e produzione di sostanze antimicrobiche: i probiotici consumano nutrienti e competono con i patogeni per le risorse. Inoltre alcuni ceppi producono batteriocine o altre molecole ad azione diretta contro agenti patogeni. Ad esempio, Limosilactobacillus reuteri produce reuterina, una sostanza con effetto battericida su vari batteri intestinali nocivi . Queste sostanze possono lisare la parete dei batteri patogeni, riducendone la crescita.
• Modulazione della risposta immunitaria intestinale: molti probiotici interagiscono con il tessuto linfoide associato all’intestino, aiutando a regolare la risposta infiammatoria. In presenza di un’infezione gastrointestinale, spesso l’infiammazione locale è eccessiva o prolungata; i probiotici possono ridurre l’infiammazione e potenziare le difese appropriate. Stimolano, ad esempio, un aumento delle Immunoglobuline A secretorie (IgA) nella mucosa, che aiutano a neutralizzare virus e batteri enteropatogeni . In questo modo si attenua la reazione infiammatoria e si favorisce una guarigione più rapida della mucosa danneggiata.
• Mantenimento dell’integrità della barriera intestinale: grazie alle azioni sopra descritte, i probiotici contribuiscono a preservare o riparare il rivestimento intestinale. Inoltre, producono metaboliti come gli acidi grassi a catena corta (acetato, butirrato) che nutrono gli enterociti e favoriscono la ricostituzione delle cellule epiteliali intestinali . Ciò aiuta a ripristinare la normale funzionalità di assorbimento e di barriera dell’intestino, accelerando la risoluzione della diarrea.
Grazie a questi meccanismi combinati – competizione con i patogeni, azione antimicrobica diretta, modulazione immunitaria e supporto trofico alla mucosa – i probiotici possono contrastare il danno infettivo-infiammatorio tipico della gastroenterite . È importante sottolineare che tali effetti sono ceppo-specifici: non tutti i probiotici agiscono allo stesso modo o con la stessa efficacia. Pertanto, la ricerca si è concentrata su “probiotici di precisione”, selezionando ceppi ben caratterizzati geneticamente e funzionalmente per specifiche indicazioni cliniche .
Dal punto di vista della sicurezza, i probiotici utilizzati in pediatria sono generalmente considerati sicuri nella popolazione sana, con rischio di effetti avversi minimo. Raramente si sono riportati eventi indesiderati (es. eccesso di gas, borborigmi) e quasi esclusivamente in popolazioni ad alto rischio (pazienti immunocompromessi o con dispositivi intravascolari) . Nei bambini sani l’incidenza di complicanze è eccezionalmente bassa e il profilo di sicurezza è ritenuto ottimo . Questo rende i probiotici un’opzione terapeutica interessante, purché impiegati correttamente, con ceppi adeguati e in aggiunta alle terapie standard.
Sopravvivenza dei probiotici: dall’acidità gastrica all’intestino
Una domanda frequente è se i probiotici somministrati per bocca riescano a sopravvivere all’acidità dello stomaco e a raggiungere vivi l’intestino, dove dovrebbero agire. In effetti, il transito gastrointestinale è un percorso irto di ostacoli per i microbi ingeriti. Il succo gastrico ha un pH estremamente acido (circa 1,5–2,5) che uccide gran parte dei batteri ingeriti . Anche i succhi pancreatici e la bile nell’intestino tenue hanno effetti detergenti e possono lisare le membrane cellulari dei batteri.
Non tutti i probiotici però soccombono a queste difese: i ceppi utilizzati come integratori sono selezionati in parte per la loro tolleranza agli ambienti acidi e ai sali biliari. Studi in vitro e in vivo mostrano che una frazione dei probiotici ingeriti riesce effettivamente a superare la barriera gastrica. In particolare, si stima che solo il 20–40% delle cellule ingerite di alcuni ceppi sopravviva al passaggio attraverso stomaco e intestino tenue . I principali fattori che riducono la vitalità sono proprio l’acidità gastrica e l’azione detergente della bile . Questa percentuale di sopravvivenza relativamente bassa spiega perché i probiotici vengano formulati con un numero molto alto di cellule vive (tipicamente miliardi di UFC per dose): bisogna compensare le perdite lungo il tragitto.
Tra i fattori che influenzano la sopravvivenza dei probiotici nel tratto digestivo, ricordiamo:
• Ceppo microbico e forma biologica: i Lattobacilli e i Bifidobatteri impiegati come probiotici hanno sviluppato una certa resistenza agli ambienti acidi, in quanto produttori loro stessi di acido lattico. Ceppi come Lactobacillus rhamnosus GG hanno dimostrato di resistere a pH molto bassi (fino a 2,5) e di sopravvivere per diverse ore nell’ambiente gastrico . Anche alcuni Bifidobacterium (es. B. longum, B. animalis BB-12) mostrano elevata tolleranza all’acidità . I lieviti come Saccharomyces boulardii sono naturalmente più resistenti all’acidità rispetto ai batteri e, inoltre, essendo eucarioti, non vengono uccisi dagli antibiotici antibatterici: questo consente loro di sopravvivere anche durante terapie antibiotiche concomitanti. Un discorso a parte meritano i probiotici sporigeni (come il genere Bacillus): questi microorganismi vengono ingeriti sotto forma di spore, forme di resistenza altamente durevoli che possono superare indenni acidi e bile. Le spore di Bacillus clausii o B. coagulans, ad esempio, sopravvivono al passaggio gastrico e germinano in forme attive solo una volta raggiunto l’intestino, dove l’ambiente è più favorevole . Ciò aumenta la probabilità che arrivino vive in colon.
• Formulazione e tecnologie protettive: l’industria ha sviluppato varie strategie per migliorare la vitalità dei probiotici. Una di queste è la microincapsulazione, ovvero rivestire le cellule probiotiche con matrici protettive (polimeri, polisaccaridi, proteine) che le schermano dall’acido gastrico . Anche capsule gastroresistenti, in grado di non disgregarsi nello stomaco ma di dissolversi solo nell’intestino, possono aumentare il numero di cellule vive che raggiunge il colon. Inoltre, i processi di liofilizzazione e conservazione sono fondamentali: bruschi sbalzi termici o un inadeguato stoccaggio possono ridurre la vitalità ancor prima dell’ingestione . È sempre consigliato attenersi alle indicazioni di conservazione del produttore (ad esempio, alcuni prodotti vanno tenuti in frigorifero per mantenere il titolo in UFC fino alla scadenza).
• Modalità di assunzione (a stomaco pieno o vuoto): curiosamente, l’efficacia di un probiotico può variare a seconda di come viene assunto. In generale, l’assunzione durante un pasto o poco prima di mangiare aiuta a tamponare l’acidità gastrica. Il cibo (soprattutto se contiene grassi e proteine) innalza temporaneamente il pH dello stomaco (verso valori di 3-4) e fornisce una sorta di “veicolo” che protegge i batteri durante il transito . Per i Lattobacilli e Bifidobatteri le evidenze suggeriscono una sopravvivenza migliore se assunti con un po’ di cibo, o entro 30 minuti prima di un pasto . S. boulardii, invece, sembra mantenere la sua vitalità in modo simile sia con che senza cibo , dunque può essere assunto indifferentemente. In ogni caso, seguire le istruzioni del produttore è utile: alcuni integratori specificano di assumere a stomaco pieno o vuoto in base a test di stabilità interni.
• Veicolo di somministrazione e accorgimenti: quando i probiotici sono in polvere (bustine) o liofilizzati, vanno disciolti in liquidi non caldi. Temperature elevate possono uccidere i fermenti: è bene quindi evitare di mescolarli in bevande bollenti. Meglio usare acqua a temperatura ambiente o un liquido freddo/temperatura corporea (ad esempio, per le bustine pediatriche, vanno bene acqua, latte a temperatura di bevuta, o soluzioni reidratanti fredde). Anche il pH del veicolo può influire: diluire i probiotici in succhi molto acidi (es. succo d’arancia) non è ideale, mentre latte o alimenti a pH neutro sono più protettivi. Per i lattanti, molte formulazioni in gocce oleose (es. L. reuteri DSM 17938 in gocce) possono essere somministrate direttamente in bocca o aggiunte al biberon (avendo cura che il latte non sia troppo caldo).
• Interazione con terapie concomitanti: un fattore cruciale è la concomitante terapia antibiotica. Se il bambino sta assumendo un antibiotico per un’infezione batterica (respiratoria, urinaria, o una gastroenterite batterica che richieda antibiotico), molti probiotici batterici (come LGG, L. reuteri, Bifidobacterium) potrebbero essere uccisi dall’antibiotico stesso. Per ovviare a questo problema si consiglia di distanziare di qualche ora l’assunzione dell’antibiotico e del probiotico (ad esempio, se l’antibiotico va dato ogni 8 ore, il probiotico si può dare a metà dell’intervallo). In questo modo la concentrazione dell’antibiotico nel lume intestinale sarà più bassa quando il probiotico transita, e una quota maggiore di cellule sopravvivrà. In alternativa, come già detto, si può optare per S. boulardii durante la terapia antibiotica, poiché essendo un lievito non viene inattivato dagli antibiotici antibatterici . Bacillus clausii è un altro caso particolare: le sue spore sono resistenti a molti antibiotici, e infatti B. clausii è stato storicamente usato in concomitanza ad antibiotici (il produttore indica l’assunzione “anche durante l’antibioticoterapia”). Tuttavia, l’efficacia clinica di Bacillus clausii nella diarrea è controversa (come vedremo più avanti).
In sintesi, non tutti i probiotici ingeriti giungono vivi nell’intestino, ma una percentuale rilevante può farlo grazie alle caratteristiche intrinseche dei ceppi e ad alcuni accorgimenti di somministrazione. Vale la pena ricordare che, anche quando sopravvivono al transito gastrointestinale, i probiotici non colonizzano in modo permanente l’intestino: essi transitano temporaneamente e vengono poi eliminati con le feci entro pochi giorni dall’interruzione dell’assunzione . Non ci sono evidenze che i ceppi probiotici orali aderiscano stabilmente alla mucosa intestinale a lungo termine . Perciò, affinché l’effetto benefico sia continuo, il probiotico va assunto quotidianamente per tutta la durata in cui si desidera l’azione (ad esempio per l’intero episodio di gastroenterite). Questo concetto è importante per capire che i probiotici non “rimangono” nell’intestino a lungo dopo la somministrazione: se se ne interrompe l’assunzione, il loro contributo diminuisce rapidamente.
Efficacia clinica dei probiotici nella gastroenterite acuta
Numerosi studi clinici hanno valutato se l’aggiunta di probiotici alla terapia della gastroenterite acuta possa effettivamente aiutare i bambini a guarire più velocemente o con sintomi meno intensi. La terapia standard della gastroenterite virale (la più comune in pediatria) prevede reidratazione orale con soluzioni saline bilanciate, rialimentazione precoce e, in alcuni casi selezionati, supplementazione di zinco . Gli antibiotici sono generalmente indicati solo nelle gastroenteriti batteriche più severe o specifiche (es. dissenteria da Shigella, colera, infezioni da Clostridioides difficile, ecc.), mentre farmaci antidiarroici o antinausea vengono usati raramente nei bambini e solo sotto controllo medico. In questo contesto, i probiotici rappresentano un trattamento complementare: l’idea è che aggiungendoli alla terapia di supporto si possa ridurre la durata della diarrea e accelerare la risoluzione dell’episodio.
Risultati di studi e meta-analisi
Le prime meta-analisi, condotte tra gli anni 2000 e 2010, hanno suggerito un beneficio significativo dei probiotici nel trattamento della diarrea acuta pediatrica. Una revisione Cochrane che ha incluso 63 studi randomizzati controllati (per un totale di oltre 8000 pazienti, soprattutto bambini) ha concluso che, in media, l’uso di probiotici riduce la durata della diarrea di circa 24 ore rispetto al placebo . Inoltre, riduceva il rischio che la diarrea si protraesse oltre 3-4 giorni . In altre parole, i bambini che assumevano probiotici avevano maggiori probabilità di risolvere la diarrea entro il terzo giorno di malattia rispetto a quelli che non li assumevano. Importante, nessun aumento di effetti avversi è stato riscontrato nei gruppi probiotico rispetto ai controlli , a conferma della buona sicurezza.
Tuttavia, queste analisi iniziali mescolavano molti studi eterogenei: differenti ceppi (non sempre ben caratterizzati), dosaggi variabili e qualità metodologiche non sempre elevate. Ad esempio, la revisione Cochrane citata includeva anche alcuni studi che hanno usato fermenti non vivi (inattivati dal calore) – tecnicamente non probiotici ma “postbiotici” – introducendo ulteriore eterogeneità . Inoltre, molti studi sono stati condotti in contesti con elevata prevalenza di rotavirus (dove l’effetto dei probiotici sembra più marcato) e in paesi a basso-medio reddito, mentre evidenze più recenti dai paesi ad alto reddito hanno dato risultati meno entusiasmanti.
Quali ceppi sono risultati efficaci? Gran parte degli studi positivi riguardavano pochi ceppi specifici. In particolare, due “probiotici” si sono ripetutamente distinti:
• Lactobacillus rhamnosus GG (LGG): è uno dei probiotici più studiati in assoluto in pediatria. Numerosi trial mostrano che, se somministrato precocemente (idealmente entro le prime 48-72 ore dall’esordio della diarrea) e a dosi sufficientemente alte, LGG può ridurre la durata della diarrea e anche la frequenza delle scariche nelle 48 ore successive all’inizio del trattamento . Ad esempio, l’uso di L. rhamnosus GG (≥10^10 UFC al giorno) per 5–7 giorni è associato a minor numero di scariche al giorno 2 di malattia e a meno probabilità che la diarrea duri oltre 4 giorni . Invece, l’effetto sul volume totale delle feci è meno chiaro (alcuni studi non hanno rilevato differenze nel volume fecale totale) . LGG sembra particolarmente utile nei casi di gastroenterite virale (es. rotavirus), dove può accorciare la fase diarroica grazie alla sua interferenza con il virus e al suo effetto sull’immunità locale.
• Saccharomyces boulardii (ceppo S. cerevisiae var. boulardii CNCM I-745): è un lievito probiotico con evidenze robuste di efficacia. Somministrato a dosi tipiche di 250–500 mg al giorno (circa 5–10 miliardi di cellule), S. boulardii ha mostrato di ridurre la durata media della diarrea di circa 1 giorno . Una meta-analisi che ha incluso 29 studi pediatrici ha confermato che aggiungere S. boulardii alla terapia standard riduce la durata della diarrea di ~1 giorno, a condizione che venga iniziato entro 72 ore dall’esordio dei sintomi . Se il probiotico viene introdotto troppo tardi durante l’episodio diarroico, infatti, il beneficio tende a scomparire. Non tutti gli studi su S. boulardii però concordano: un’altra meta-analisi (Feizizadeh et al.) non ha trovato un effetto chiaro in bambini con diarrea acuta , segno che potrebbero esistere differenze tra popolazioni o protocolli studiati. In generale comunque S. boulardii è considerato uno dei probiotici con le evidenze più solide nel ridurre durata e intensità della gastroenterite.
A fianco di LGG e S. boulardii, altri ceppi con evidenze (seppur meno robuste, spesso singoli studi o meta-analisi più piccole) includono:
• Lactobacillus reuteri DSM 17938: questo ceppo, originariamente isolato da latte materno, ha mostrato efficacia sia in studi individuali sia in meta-analisi recenti. Somministrato a dosi di 1–4 × 10^8 UFC die per 5–7 giorni, L. reuteri DSM 17938 può ridurre la durata della diarrea e la necessità di ricovero . Una meta-analisi del 2019 ha confermato una riduzione della durata media della diarrea e dei giorni di ospedalizzazione nei bambini trattati con L. reuteri rispetto al controllo . Questo probiotico è anche noto per avere effetti benefici nella prevenzione delle coliche infantili e in alcune diarree nosocomiali, suggerendo un buon profilo di azione sul microbiota pediatrico.
• Combinazione di L. rhamnosus 19070-2 + L. reuteri DSM 12246: si tratta di due ceppi somministrati insieme, studiati in uno studio clinico randomizzato nel 2002 su bambini con diarrea acuta. In quel trial (seppur condotto su un campione relativamente piccolo di ~30 bambini per gruppo), la combinazione ha significativamente ridotto la durata della diarrea rispetto al placebo . Sulla base di quell’evidenza e di pochi altri dati, questo duo di ceppi è stato incluso tra quelli potenzialmente utili. Tuttavia, va notato che l’evidenza qui è di qualità molto bassa (un singolo RCT di piccole dimensioni); pertanto l’uso di questa combinazione è meno diffuso rispetto a LGG o S. boulardii.
• Enterococcus faecium SF68: non nominato esplicitamente nelle linee guida recenti, ma presente in alcuni prodotti commerciali, questo ceppo (precedentemente classificato come Enterococcus o Streptococcus “faecium” SF68) è stato studiato in alcune trial negli anni passati, mostrando qualche beneficio nel ridurre la diarrea soprattutto associata ad antibiotici. Nella revisione Cochrane citata era tra i probiotici valutati (5 studi) . Oggi è meno utilizzato singolarmente, ma lo citiamo per completezza storica.
In termini di beneficio clinico atteso, quanto può accorciarsi la diarrea con i probiotici? Le meta-analisi suggeriscono un guadagno modesto ma significativo: circa 1 giorno in meno di diarrea in media . Alcuni studi riportano anche una riduzione dell’intensità dei sintomi (meno scariche al giorno, vomito meno frequente, rapido recupero dell’appetito) e talora una diminuzione della durata dell’ospedalizzazione nei bambini ricoverati . Ad esempio, un bambino con gastroenterite rotavirus che tipicamente avrebbe diarrea per 5-6 giorni potrebbe ridurre a 4-5 giorni assumendo un probiotico efficace precocemente. Ovviamente si tratta di medie: il beneficio individuale può variare (alcuni bimbi possono rispondere molto bene con risoluzione in 48 ore, altri non trarne apparente vantaggio). Non si tratta di una “cura miracolosa” immediata, ma di un aiuto che in media accorcia i tempi di guarigione e rende leggermente più blando il decorso.
Gastroenterite virale vs batterica: ruolo dei probiotici
La maggior parte delle gastroenteriti in età pediatrica ha origine virale (rotavirus, norovirus, adenovirus, astrovirus, ecc.). In queste forme la terapia è sintomatica e di supporto, e – come visto – i probiotici possono offrire un beneficio aggiuntivo nel favorire la guarigione più rapida. Le evidenze di efficacia dei ceppi come LGG, S. boulardii o L. reuteri provengono in gran parte da studi su gastroenteriti presumibilmente virali, spesso rotavirus (specie prima dell’introduzione diffusa del vaccino anti-rotavirus). Infatti, alcuni probiotici mostrano attività anti-rotavirus specifiche: LGG ad esempio produce sostanze che inibiscono la replicazione del rotavirus e ne blocca l’ingresso nelle cellule intestinali, mentre S. boulardii sembra interferire con tossine e proteine virali coinvolte nella patogenesi. È quindi nel contesto di gastroenteriti virali che l’utilizzo di probiotici ha trovato la sua prima e più ampia applicazione.
Nel caso di gastroenteriti batteriche, il ruolo dei probiotici è meno definito ma comunque potenzialmente utile. Alcune infezioni batteriche gastrointestinali (es. Salmonella, Escherichia coli enterotossigeni, Campylobacter) spesso si risolvono spontaneamente con la sola reidratazione; in altri casi più gravi (Shigella dysenteriae, colera, o infezioni invasive da Salmonella Typhi, Yersinia, ecc.) si ricorre a antibiotici mirati. In generale, l’uso dell’antibiotico nelle diarree infantili va valutato con attenzione (es. è controindicato in alcuni ceppi di E. coli produttori di tossine Shiga). Quando però un antibiotico è necessario, l’associazione di un probiotico come S. boulardii o LGG può essere benefica nel mitigare gli effetti collaterali dell’antibiotico stesso e nel prevenire squilibri eccessivi del microbiota. Durante un episodio di gastroenterite batterica trattata con antibiotici, il probiotico funge da “sostegno” alla flora intestinale buona che l’antibiotico tende a distruggere. Studi specifici sulle gastroenteriti batteriche trattate con probiotici sono meno numerosi rispetto a quelli sulle forme virali, ma possiamo estrapolare da altre evidenze: ad esempio, nei bambini con infezione da Clostridioides difficile (diarrea post-antibiotica severa) l’uso di S. boulardii ha mostrato di ridurre recidive e favorire l’eradicazione in combinazione con la terapia antibiotica standard. Anche in diarree batteriche non da C. difficile, l’uso di probiotici può aiutare a ristabilire prima una flora equilibrata dopo la clearance del patogeno.
Un aspetto particolare delle gastroenteriti batteriche è che alcuni probiotici producono sostanze antimicrobiche che possono agire anche su batteri enteropatogeni. Ad esempio, L. reuteri (sia DSM 17938 sia altri ceppi simili) produce reuterina che è attiva contro ceppi patogeni come E. coli e Clostridi. S. boulardii secerne una proteasi che inattiva le tossine di Clostridioides difficile e E. coli enterotossigeno. Questi meccanismi suggeriscono che i probiotici potrebbero ridurre la carica di agenti patogeni batterici nell’intestino e abbreviare la fase infettiva. Ovviamente, se l’infezione batterica è invasiva o severa, i probiotici da soli non bastano: non sostituiscono l’antibiotico quando questo è indicato, ma lo affiancano.
Diarrea associata ad antibiotici (AAD) e prevenzione della disbiosi
Una situazione frequente, distinta dalla gastroenterite infettiva classica, è la diarrea associata all’uso di antibiotici (AAD). Molti bambini, durante o subito dopo un ciclo di antibiotico per otite, faringite, bronchite ecc., sviluppano feci liquide a causa dell’alterazione della flora intestinale. In alcuni casi (fortunatamente rari nei bambini) l’antibiotico può scatenare un’infezione da Clostridioides difficile, responsabile di colite pseudomembranosa. I probiotici giocano un ruolo importante in questo contesto: numerose evidenze supportano l’uso di alcuni ceppi per prevenire l’insorgenza di diarrea associata ad antibiotici o per attenuarne la durata e severità.
In particolare, LGG e S. boulardii sono i ceppi con maggiore prova di efficacia in ambito AAD. Analisi combinate di studi clinici mostrano che somministrare LGG o S. boulardii fin dal primo giorno di terapia antibiotica riduce significativamente la probabilità che compaia diarrea . Le linee guida internazionali (come vedremo) raccomandano fortemente questi due probiotici come misura di prevenzione nelle terapie antibiotiche pediatriche . Tipicamente si usano dosi alte (≥5 miliardi di UFC al giorno), da continuare per tutto il periodo di antibiotico e per circa 1–2 settimane dopo la fine , in modo da coprire anche il periodo in cui la flora deve riequilibrarsi. I risultati medi indicano una riduzione quasi del 50% dell’incidenza di diarrea da antibiotico nei bambini trattati con probiotici rispetto al placebo . Anche nel caso si manifesti comunque diarrea, chi ha assunto probiotici tende ad averla di entità più lieve e di durata inferiore.
Per esempio, un famoso studio in doppio cieco su bambini trattati con amoxicillina-clavulanato ha mostrato che LGG riduceva l’incidenza di diarrea dal 26% (placebo) a circa il 8-10% (LGG). Similmente, S. boulardii in altri studi ha ridotto la diarrea associata ad antibiotici (inclusa quella da C. difficile). Questi benefici sono coerenti con il fatto che il probiotico mantiene un equilibrio di microbiota durante la perturbazione causata dall’antibiotico, prevenendo la crescita eccessiva di patogeni opportunisti (come C. difficile o Candida). Come accennato, S. boulardii ha un’attività specifica anti-C. difficile (inattiva le tossine A e B) ed è resistente agli antibiotici, il che lo rende ideale in combinazione con essi.
Va comunque chiarito che qui parliamo soprattutto di prevenzione. Se un bambino sta già avendo diarrea da antibiotico, il probiotico può essere iniziato lo stesso (o continuato) per aiutare a risolverla più rapidamente, ma gli studi sono più focalizzati sulla profilassi sin dall’inizio della terapia antimicrobica. Ad ogni modo, data la sicurezza di questi interventi, molti pediatri italiani li hanno adottati sistematicamente: un recente sondaggio ha rilevato che oltre l’80% dei pediatri di famiglia in Italia prescrive abitualmente probiotici durante le terapie antibiotiche per prevenire disturbi intestinali . LGG era il ceppo più consigliato (circa 92% dei pediatri), seguito da S. boulardii (42%) . Ciò riflette la fiducia pratica in questi interventi, anche in assenza di linee guida nazionali ufficiali uniformi (che infatti mancano, portando a variabilità nelle dosi e durata prescritta)
Limiti delle evidenze e nuove ricerche
Sebbene i dati globali suggeriscano benefici reali, la robustezza delle evidenze è stata messa in discussione da studi più recenti, soprattutto nei paesi ad alto reddito. Due grandi studi randomizzati condotti negli Stati Uniti (Schnadower et al., 2018, su Lactobacillus GG; e un altro su L. reuteri, 2020) non hanno trovato differenze significative nella durata della diarrea tra bambini che ricevevano probiotici e quelli che ricevevano placebo. Questi studi, caratterizzati da alta qualità metodologica, hanno contribuito a “raffreddare” parte dell’entusiasmo iniziale. Una revisione sistematica del 2020 (comprendente 89 studi) commissionata dall’American Gastroenterological Association (AGA) ha concluso che mancano evidenze certe di beneficio dei probiotici nella gastroenterite acuta pediatrica, soprattutto generalizzando ai paesi sviluppati . Si è osservato che molti studi positivi provenivano da contesti diversi (genetica della popolazione, dieta, patogeni endemici differenti) e che tali risultati non erano automaticamente applicabili ad altre realtà .
Un aggiornamento Cochrane più recente (2020) che ha incluso 82 trial, di cui alcuni ampi a basso rischio di bias, ha riportato che i probiotici probabilmente non fanno una grande differenza nel numero di persone con diarrea che dura oltre 48 ore e che l’effetto sulla riduzione della durata rimane incerto . Un’ulteriore meta-analisi del 2021 focalizzata sui paesi sviluppati ha concluso che nei bambini del mondo sviluppato i probiotici (e simbiotici) non riducono la durata della diarrea in maniera significativa .
Come conciliare queste discrepanze? Una possibile spiegazione è che nei paesi in via di sviluppo (o situazioni con diarree più gravi, e frequente disidratazione) l’impatto aggiuntivo dei probiotici sia più evidente, mentre nei paesi industrializzati, dove la maggior parte delle gastroenteriti è gestita bene a domicilio, con decorso benigno e breve, l’effetto dei probiotici si “perda nel rumore di fondo”. Ad esempio, un bambino europeo con gastroenterite da norovirus spesso guarisce in 2-3 giorni da solo; aggiungere un probiotico potrebbe non accorciare ulteriormente un decorso già breve. Viceversa, in un bambino malnutrito con rotavirus, che senza probiotico avrebbe diarrea per 7 giorni, l’effetto di ridurla a 6 giorni diventa clinicamente più apprezzabile. Inoltre, fattori come il tempo di inizio del trattamento (dare il probiotico il primo giorno fa più differenza che darlo al terzo-quarto giorno) e il ceppo specifico (usare un prodotto inefficace equivale ovviamente a nessun beneficio) possono aver influenzato gli esiti contrastanti.
In definitiva, le evidenze vanno interpretate con cautela: esistono dati a supporto dell’efficacia di alcuni probiotici nella diarrea acuta, ma non costituiscono ancora una prova “forte” e definitiva. Per questo motivo, le varie società scientifiche hanno emesso raccomandazioni prudenti, come vedremo di seguito.
Linee guida ufficiali e raccomandazioni
Le linee guida pediatriche internazionali riconoscono il possibile ruolo dei probiotici nella gastroenterite acuta, ma con diversi gradi di entusiasmo. È fondamentale sottolineare che tutte le linee guida concordano sul fatto che la terapia principale resta la reidratazione (preferibilmente orale, endovena se necessario) e la rialimentazione precoce; i probiotici sono considerati un’opzione aggiuntiva, non sostitutiva.
Linee guida europee (ESPGHAN/ESPID)
In Europa, un riferimento importante è rappresentato dalle linee guida congiunte ESPGHAN/ESPID (Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica e Società Europea di Infettivologia Pediatrica). Già nell’aggiornamento del 2014, queste linee guida includevano l’utilizzo di probiotici come intervento aggiuntivo facoltativo nella gestione della gastroenterite acuta in bambini precedentemente sani . All’epoca si affermava che alcuni ceppi specifici potevano essere utilizzati per ridurre durata e intensità della diarrea, purché in aggiunta alla terapia reidratante standard.
Successivamente, l’ESPGHAN Working Group on Probiotics and Prebiotics ha pubblicato nel 2020 e aggiornato nel 2023 dei position paper focalizzati proprio su probiotici e disturbi gastrointestinali pediatrici. In tali documenti vengono date raccomandazioni dettagliate su quali ceppi utilizzare. In particolare, l’ESPGHAN raccomanda l’uso, in corso di gastroenterite acuta pediatrica, esclusivamente di specifici probiotici che hanno dimostrato efficacia in studi clinici :
• Saccharomyces boulardii CNCM I-745 – (Qualità evidenza: bassa/very low) – Dose consigliata 250–750 mg al dì (≈5–10 miliardi di cellule), per almeno 5 giorni .
• Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) – (Qualità evidenza: molto bassa) – Dose minima 10^10 UFC al dì, per 5 giorni o più .
• Lactobacillus reuteri DSM 17938 – (Qualità evidenza: bassa/molto bassa) – Dose 1–4 × 10^8 UFC al dì, per almeno 5 giorni .
• Combinazione L. rhamnosus 19070-2 + L. reuteri DSM 12246 – (Qualità evidenza: molto bassa) – Dose 2 × 10^10 UFC/dì per ciascun ceppo, per 5 giorni .
Gli stessi documenti sconsigliano invece l’uso di probiotici per i quali gli studi non hanno mostrato beneficio. In particolare è vivamente sconsigliata la combinazione Lactobacillus helveticus R0052 + L. rhamnosus R0011 (un mix presente in alcuni prodotti in passato), in quanto prove di efficacia mancanti o negative . Viene inoltre sconsigliato debolmente l’uso dei ceppi sporigeni di Bacillus clausii (ceppi O/C, SIN, N/R, T) nella gastroenterite, a causa di evidenze di qualità molto bassa e risultati clinici non convincenti . Queste indicazioni sottolineano il concetto di specificità di ceppo: non è corretto dire “un probiotico vale l’altro” – solo i ceppi testati con successo andrebbero usati, mentre altri in quello specifico contesto non hanno dimostrato efficacia.
Le linee guida ESPGHAN quindi includono i probiotici tra le opzioni terapeutiche per la diarrea acuta, ma con alcune precisazioni importanti: le evidenze a favore, pur presenti, sono classificate come “bassa certezza” (low/very low certainty) ; inoltre, i probiotici non sono definiti indispensabili ma facoltativi (“possono essere usati” piuttosto che “devono essere usati”). Infatti, nella pratica clinica europea, molti medici li consigliano, ma altri – soprattutto nei paesi nordici – li usano meno, enfatizzando solo idratazione e dieta. Le linee guida NICE del Regno Unito, ad esempio, in passato non raccomandavano l’uso routinario di probiotici in tutti i bambini con gastroenterite, riservandoli a casi selezionati. La differenza con l’ESPGHAN stava soprattutto nel grado della raccomandazione: ESPGHAN/ESPID facevano una raccomandazione più forte a favore di alcuni probiotici rispetto a NICE .
Oltre alla gestione della singola gastroenterite, l’ESPGHAN ha prodotto raccomandazioni sulla prevenzione di diarrea nosocomiale e AAD: anche in quei contesti, LGG e S. boulardii sono citati come i probiotici di scelta (ad esempio, L. rhamnosus GG almeno 10^9/dì durante i ricoveri per ridurre le diarree nosocomiali, soprattutto da rotavirus ). In generale comunque, l’ESPGHAN conclude che i probiotici possono essere utili ma non sono essenziali: rimane prioritario applicare le misure standard (e nel caso della prevenzione, vaccinare contro rotavirus, usare accorgimenti igienici, ecc.).
Da notare che, nel contesto italiano, non esistono linee guida nazionali formalmente emanate sulla gestione della gastroenterite acute che aggiungano molto a quelle internazionali. Società come la SIP (Società Italiana di Pediatria) e la SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica) hanno diffuso aggiornamenti e articoli divulgativi ai pediatri, essenzialmente in linea con ESPGHAN. Ad esempio, viene ribadito che alcuni probiotici possono ridurre di circa 1 giorno la durata della diarrea acuta nei bambini , ma al contempo si sconsiglia l’uso di altri fermenti non documentati. Non c’è però un protocollo “ufficiale” unificato italiano, tant’è che uno studio recente ha evidenziato come i pediatri di famiglia adottino pratiche variabili e auspicano linee guida più chiare e condivise sull’uso dei probiotici con antibiotico .
Linee guida americane (AGA/AAP)
Negli Stati Uniti, l’orientamento ufficiale è più cauto. Nel 2020 l’American Gastroenterological Association (AGA) ha pubblicato linee guida sul ruolo dei probiotici in varie patologie, includendo la diarrea infettiva acuta pediatrica. La raccomandazione dell’AGA è stata di non utilizzare routinariamente probiotici nei bambini con gastroenterite infettiva acuta, data l’assenza di chiari benefici nei loro trials (raccomandazione “condizionale”, evidenza di qualità moderata) . In pratica, l’AGA suggerisce di evitare l’uso di probiotici di default, lasciandolo eventualmente a casi individuali o nell’ambito di protocolli sperimentali. Questa posizione è influenzata dai grandi studi nordamericani che – come detto – non mostravano vantaggi nell’aggiunta di Lactobacillus GG o L. reuteri in bambini già ben idratati e trattati.
L’American Academy of Pediatrics (AAP), dalla sua, non ha linee guida formali dedicate ai probiotici nella gastroenterite, ma nei testi di riferimento (es. Red Book e manuali di pediatria) viene citato che alcuni probiotici possono accorciare moderatamente la diarrea, se iniziati precocemente, ma l’evidenza è variabile. L’AAP enfatizza principalmente la reidratazione orale e l’alimentazione adeguata, menzionando i probiotici solo come possibile aggiunta. Non c’è una lista di ceppi raccomandati dall’AAP, ma riconosce LGG e S. boulardii come i più studiati.
Riassumendo: in Europa le linee guida includono con prudenza i probiotici, definendo quali ceppi usare e quali no, mentre negli USA le linee guida sono più scettiche e generalmente non ne incoraggiano l’uso di routine. Entrambe però concordano sul fatto che l’evidenza non è definitiva e che servono ulteriori studi di alta qualità per chiarire quali bambini possano trarre il massimo beneficio . È interessante notare che malgrado le linee AGA negative, molti pediatri e gastroenterologi negli USA continuano comunque a usare probiotici (specie per prevenzione AAD), segno che a livello pratico l’esperienza clinica e la percezione di innocuità favoriscono il loro impiego, soprattutto considerando che male non fanno.
Le linee guida OMS sulla gestione della diarrea nei bambini (aggiornate al 2017) menzionano i probiotici solo brevemente: l’OMS sottolinea l’importanza dello zinco e della reidratazione, e afferma che “probiotici come Lactobacillus GG possono ridurre la durata della diarrea” ma non li include tra le raccomandazioni fondamentali, probabilmente per il costo e la disponibilità limitata in molti paesi in via di sviluppo. Dunque, a livello globale, i probiotici sono considerati un’opzione valida ma non essenziale.
In conclusione delle sezioni di evidenza e linee guida: sì, esistono evidenze scientifiche a supporto dell’uso di specifici probiotici nella gastroenterite acuta pediatrica, ma non si tratta di evidenze “granitiche”. Il beneficio atteso è modesto (qualche giorno in meno di diarrea nel migliore dei casi) e la sua rilevanza clinica varia con il contesto. Le linee guida ufficiali riflettono questa ambivalenza, includendo i probiotici come possibilità ma non elevandoli al rango di terapia obbligatoria. L’approccio più ragionevole è selezionare accuratamente il ceppo probiotico se si decide di usarlo, informare i genitori che il vantaggio c’è ma è moderato, e ovviamente non trascurare le terapie base (idratazione e alimentazione). Nella prossima sezione vedremo come somministrare correttamente i probiotici in pediatria per massimizzarne l’efficacia.
Somministrazione in pediatria: formulazioni, dosaggio e durata
Nel prescrivere o consigliare un probiotico a un bambino con diarrea, bisogna tenere conto di vari aspetti pratici: forma farmaceutica, quantità di microorganismi (UFC) da assumere, durata del trattamento, eventuale prodotto multi-ceppo vs singolo ceppo, e compatibilità con l’età pediatrica.
Formati disponibili e scelta in base all’età
I probiotici per uso pediatrico si trovano in diverse formulazioni. Le principali sono:
• Gocce orali: soluzione o sospensione contenente il probiotico, da dosare in gocce. Sono molto comode per neonati e lattanti che non assumono ancora solidi. Ad esempio, L. reuteri DSM 17938 è venduto in flaconcini con contagocce (5 gocce ~ 1×10^8 UFC). Anche alcune miscele di più ceppi sono disponibili in gocce, spesso con oli MCT come veicolo. Le gocce si possono somministrare direttamente in bocca o mescolare in un cucchiaino di latte/acqua. Vantaggio: facilità di somministrazione ai più piccoli. Svantaggio: limitato volume di UFC per dose (spesso non più di 10^8–10^9 per dose standard, quindi a volte dosaggio non altissimo, ma adeguato per neonati).
• Bustine di polvere (sachets): contengono polvere liofilizzata da sciogliere in acqua o altri liquidi. Molti probiotici (LGG, S. boulardii, mix di bifido/lattobacilli) sono venduti così. Il contenuto di solito è di almeno alcuni miliardi di UFC per bustina. Le bustine sono adatte a bambini un po’ più grandi (diciamo dall’età in cui bevono da tazza o cucchiaino, ~6 mesi in su) e ai bambini in età prescolare. Si possono sciogliere in poca acqua, succo, latte, soluzione reidratante orale o purea, purché freddi/tiepidi. È importante assicurarsi che il bambino assuma l’intero contenuto (magari mescolando la polvere in una piccola quantità di liquido da bere tutta). Se messe nel biberon, fare attenzione a non lasciarle troppo a lungo reidratate a temperatura ambiente (meglio consumare subito).
• Capsule o compresse: alcune formulazioni sono in capsule deglutibili o compresse masticabili. Le capsule a volte sono apribili, così da mescolare la polvere in cibo/liquido; altre sono gastroresistenti e vanno deglutite intere (queste ultime non adatte ai bimbi piccoli per rischio di soffocamento). Le compresse masticabili esistono per alcuni probiotici (tipo compresse al gusto di frutta con lactobacilli, pensate per bimbi più grandi che possono masticare). In generale, l’uso di capsule è riservato a bambini in età scolare capaci di deglutirle, o agli adolescenti. Per i più piccoli, se si ha solo la capsula, la si può aprire e versare il contenuto in acqua/succo (sempre verificando istruzioni: se gastroresistente, aprirla vanifica il rivestimento).
• Flaconcini monodose liquidi: ad esempio Bacillus clausii è noto per essere venduto in flaconcini bevibili contenenti una sospensione di spore. Anche alcuni lactobacilli multi-ceppo sono disponibili in flaconcini (magari con tappo separatore da premere per miscelare la polvere al liquido al momento dell’uso). Questi flaconcini sono di solito ben accetti dai bambini perché sono dolciastri o comunque neutri, e si bevono velocemente. Sono un’opzione per l’età prescolare e oltre, o anche per lattanti se si versano in biberon (ma in quel caso equivalgono alla somministrazione di un liquido, simile alle gocce).
In termini di efficacia, non c’è differenza intrinseca tra i vari formati: gocce, bustine, capsule o flaconcini funzionano se contengono il ceppo giusto in quantità adeguata e se sono maneggiati correttamente. La scelta dipende quindi da età e preferenze: per un neonato useremo gocce, per un bambino di 2 anni può andar bene una bustina nel succo, per uno di 7 anni magari una compressa masticabile gusto fragola se disponibile. L’importante è che il bambino assuma effettivamente il prodotto ogni giorno.
Mono-ceppo vs multi-ceppo: importa?
Molti prodotti in commercio contengono miscele di ceppi diversi (multi-ceppo), mentre altri ne contengono uno solo (mono-ceppo). Viene spontaneo chiedersi se più ceppi “insieme” siano meglio di uno solo. La risposta non è semplice: in teoria, miscele multi-ceppo potrebbero avere un effetto sinergico (ad esempio un ceppo potrebbe colonizzare meglio il tenue e un altro il colon, oppure potrebbero avere meccanismi complementari). Alcuni studi su modelli animali e in vitro indicano che combinare ceppi diversi può aumentare la capacità di colonizzazione e l’effetto complessivo . Tuttavia, nelle sperimentazioni cliniche sulla diarrea pediatrica non c’è evidenza chiara che i prodotti multi-ceppo funzionino meglio dei singoli ceppi. In effetti, molte delle prove di efficacia più solide riguardano ceppi usati da soli (LGG da solo, S. boulardii da solo, L. reuteri da solo). Mischiare tanti fermenti non garantisce un risultato: se la miscela contiene un ceppo efficace e altri inutili, il beneficio lo farà il ceppo efficace mentre gli altri sono “riempitivi”. Se la miscela contiene solo ceppi non efficaci, non avrà benefici. E se contiene più ceppi efficaci, non è detto che l’effetto raddoppi: potrebbe semplicemente essere simile a quello del migliore dei singoli ceppi.
Ci sono comunque alcune formulazioni combinate studiate: ad esempio la combinazione L. rhamnosus 19070-2 + L. reuteri DSM 12246 di cui parlavamo ha mostrato efficacia, così come combinazioni di alcuni Bifidobatteri + Lattobacilli (presenti in prodotti per lattanti) hanno dato esiti incoraggianti in riduzione di diarrea nosocomiale e da antibiotici. Ma sono casi specifici. In generale, non vi è attualmente una raccomandazione a preferire prodotti multi-ceppo: conta quali ceppi ci sono, non quanti. Un mix di 7 ceppi qualsiasi, venduto magari con un alto numero totale di UFC, non è detto che sia meglio di 1 ceppo singolo mirato; anzi, ESPGHAN sottolinea di usare “ceppi con benefici documentati” e scoraggia l’idea di prendere un probiotico generico multi-specie sperando copra tutto .
Quindi, nella scelta pratica: va bene sia un singolo ceppo sia una combinazione, purché includa i ceppi giusti. Ad esempio, un prodotto che contenga L. rhamnosus GG + Bifidobacterium lactis può andar bene (LGG è l’ingrediente chiave, il Bifido è neutro o lievemente utile); un prodotto con 4 ceppi dei quali nessuno è LGG/S. boulardii/L. reuteri ecc. potrebbe non dare risultati perché manca il “principio attivo” documentato. Attenzione anche al dosaggio per ceppo nei multi-ceppo: se in un flaconcino ci sono 6 ceppi e un totale di 2 miliardi di UFC, significa che magari di LGG ce ne sono solo 0,3 miliardi (300 milioni), dose subottimale. Questo per dire che il multi-ceppo spesso diluisce la dose di ciascun componente. Quindi assicurarsi che nel multi-ceppo eventuale i ceppi importanti siano presenti in quantità sufficienti.
Dosaggio: quanti miliardi servono?
Il dosaggio ottimale dipende dal ceppo, ma ci sono alcune linee generali. Spesso si ragiona in termini di UFC al giorno (unità formanti colonia, cioè cellule vive). Le linee guida ESPGHAN suggeriscono i seguenti dosaggi minimi efficaci :
• Lactobacillus rhamnosus GG: almeno 1 × 10^10 UFC/die (10 miliardi al giorno). Alcuni studi hanno usato anche dosi molto superiori (es. 10^12) senza problemi di sicurezza , ma 10^10 è considerata la soglia minima per vedere effetti. In pratica, molte formulazioni contengono 10 miliardi in 1-2 bustine, quindi la posologia sarà 1 bustina bis die da 5 miliardi, oppure 1 bustina unica da 10 miliardi die.
• Saccharomyces boulardii: in genere 250–500 mg/die, che corrispondono a circa 5–10 miliardi di cellule vive al giorno (la conversione mg→UFC dipende dal prodotto, ma ad esempio una capsula da 250 mg di S. boulardii liofilizzato tipicamente ha 5 × 10^9 UFC). Si può usare 250 mg 2 volte al dì (mattina e sera) nelle diarree più intense, ottenendo 500 mg totali. Anche 250 mg die è risultato efficace in studi su diarrea lieve, ma la maggior parte delle evidenze consiglia almeno 500 mg al dì.
• Lactobacillus reuteri DSM 17938: dose efficace 1 × 10^8 fino a 4 × 10^8 UFC/die. Questo è un dosaggio molto più basso in termini numerici rispetto a LGG, ma L. reuteri è spesso formulato in gocce concentrate. Ad esempio, 5 gocce di un noto prodotto contengono 100 milioni (1×10^8) di UFC; alcuni studi hanno usato 10 gocce (2×10^8) o 20 gocce (4×10^8) al giorno. Non sembrano necessarie dosi nell’ordine dei miliardi, forse perché L. reuteri colonizza transitoriamente più efficacemente o produce metaboliti attivi a basse concentrazioni. NB: altri ceppi di L. reuteri differenti da DSM 17938 possono avere dosaggi diversi, ma quel ceppo specifico è ben definito così.
• Combinazione L. rhamnosus 19070-2 + L. reuteri DSM 12246: raccomandata alla dose di 2 × 10^10 UFC/die per ciascun ceppo , quindi in totale 4 × 10^10 UFC (40 miliardi) al giorno. Di solito somministrati come 2 dosi separate (es. mattina e sera 20 mld + 20 mld). Queste quantità sono elevate, ma erano quelle usate nel piccolo trial originario. Non esistendo molti prodotti commerciali con questi ceppi, l’applicazione pratica è limitata.
• Bacillus clausii: tradizionalmente in Italia si è usato in fialette da 2 miliardi di spore, tipicamente 2–3 fialette al giorno (quindi 4–6 miliardi di spore/die). Le linee guida però non lo raccomandano specificamente per efficacia; tuttavia, se un pediatra lo prescrive, queste sono le dosi comunemente impiegate in passato. B. clausii è più usato in prevenzione di disbiosi antibiotica che nel trattamento di gastroenterite in sé.
• Altri ceppi (E. faecium SF68, B. lactis BB-12, Streptococcus thermophilus, etc.): generalmente dosaggi di 1–10 miliardi/die, ma non essendo raccomandati specificamente, non c’è un numero “ufficiale” da seguire per la diarrea acuta.
In pratica, per la maggior parte dei probiotici pediatrici disponibili, un dosaggio giornaliero compreso tra 5 e 10 miliardi di UFC totali è considerato adeguato . Questo range viene effettivamente usato dalla maggioranza dei pediatri . Dosi inferiori (es. 1–2 miliardi/die) potrebbero essere sub-terapeutiche per ceppi come LGG, mentre dosi molto superiori (>10^11) non sono risultate tossiche ma probabilmente non aggiungono beneficio proporzionale (effetto soglia). In ogni caso, il sovradosaggio di probiotici è raro e generalmente non pericoloso: studi hanno somministrato LGG a dosi enormi (anche 10^12 due volte al dì) senza osservare eventi avversi seri . Quindi, più che altro, il limite superiore è posto dal buon senso (non serve dare 50 miliardi se 5 sono sufficienti) e da considerazioni economiche.
Durata della somministrazione
La tempistica è importante: come ripetuto, i probiotici vanno iniziati il prima possibile dall’inizio della gastroenterite, idealmente appena il bambino riesce ad assumere liquidi per bocca (subito dopo la fase di reidratazione acuta). Prima si iniziano, maggiore è la probabilità di influenzare favorevolmente il decorso .
Per quanto riguarda la durata totale, le raccomandazioni indicano una durata minima di 5 giorni di trattamento . Questo perché gli studi che mostravano efficacia di solito somministravano il probiotico per 5–7 giorni consecutivi. In molti casi la diarrea si risolve anche prima, ma è consigliabile proseguire il probiotico per qualche giorno dopo la scomparsa dei sintomi, in modo da favorire il completo riequilibrio del microbiota intestinale. Ad esempio, se un bimbo smette di avere scariche dopo 3 giorni ma ha iniziato un ciclo di probiotico, conviene continuare fino a completare almeno 5 giorni totali.
Se la diarrea persiste oltre 5 giorni, si può certamente continuare il probiotico fino a guarigione, o anche qualche giorno in più preventivamente. Non c’è un limite rigido: trattandosi di microrganismi commensali, possono essere assunti anche per settimane. Alcuni medici suggeriscono di estendere a 7–10 giorni totali il trattamento, soprattutto se il bambino ha assunto antibiotici o ha ancora feci non formate. In caso di diarrea associata ad antibiotico, come visto, è prassi mantenere il probiotico per 1–2 settimane dopo la fine dell’antibiotico , per ridurre il rischio di recidive tardive.
Riassumendo linee generali per la diarrea acuta infettiva comune:
• Inizio: appena possibile, idealmente entro 48-72 ore dall’esordio dei sintomi.
• Durata minima: 5 giorni consecutivi.
• Durata ottimale: fino a 7-8 giorni o comunque almeno 2 giorni dopo la normalizzazione delle feci.
• Se in terapia antibiotica: continuare fino a 1-2 settimane post-antibiotico per prevenire AAD.
Oltre questi periodi, continuare non è nocivo ma probabilmente inutile per quell’episodio (a meno che il bimbo non entri in uno stato di diarrea protratta o sviluppi IBS post-infettiva, condizioni in cui alcuni prolungano l’uso, ma sono casi particolari).
Altre indicazioni pratiche
Somministrazione quotidiana: i probiotici in genere vanno dati ogni giorno, ma non necessariamente più volte al giorno, a meno che la dose giornaliera sia suddivisa in più somministrazioni. Ad esempio, se sono richiesti 10 miliardi/die, si può fare 5 mld mattina + 5 mld sera, oppure tutti e 10 insieme. Dal punto di vista farmacodinamico, dare piccole dosi più volte potrebbe mantenere un livello più costante nel lume intestinale, ma non ci sono prove che sia fondamentale. Seguire le indicazioni del produttore o la posologia usata negli studi clinici è la scelta migliore. Molti protocolli usano 2 somministrazioni al giorno.
Associazione con soluzioni reidratanti: è del tutto possibile e anzi comodo sciogliere la bustina probiotica direttamente nella soluzione reidratante orale (SRO) che il bambino sta bevendo a piccoli sorsi. Questo unisce i due interventi. Basta fare attenzione che la SRO non sia calda e che venga consumata in tempi brevi, poiché la SRO contiene sali e zuccheri che a temperatura ambiente potrebbero far “attivare” i fermenti; berla entro un’ora circa garantisce di assumere cellule vive.
Alimentazione e probiotici: durante la gastroenterite si raccomanda la pronta rialimentazione. Il probiotico può essere mischiato anche in cibi semi-solidi come yogurt, purea di frutta, semolino, purché non caldi. Anzi, mescolare il probiotico in un pochino di yogurt (se il bambino lo tollera) può fornire un ulteriore aiuto, perché lo yogurt stesso contiene fermenti benefici e aiuta a tamponare l’acidità (inoltre il lattosio del yogurt è in parte predigerito, quindi è uno dei pochi latticini concessi presto). Questo però è un dettaglio: va bene anche acqua o latte artificiale.
Adesione al trattamento: spiegare ai genitori l’importanza di dare il probiotico ogni giorno per l’intera durata prescritta, anche se il bambino sta meglio dopo 2-3 giorni. Spesso appena il piccolo migliora, i genitori sospendono integratori e farmaci; nel caso del probiotico, continuarlo per quei pochi giorni in più può consolidare il beneficio (e male non fa). Se il bimbo vomita subito dopo aver preso il probiotico, la dose può essere ripetuta in seguito (soprattutto se era un episodio di vomito acuto e il prodotto non era protetto, potrebbe essere stato espulso).
Controindicazioni: pochissime. In bambini gravemente immunodepressi (es. in chemioterapia intensa, trapiantati) o con cateteri centrali a permanenza, c’è un raro rischio di infezioni da translocazione (batteriemia/fungemia da probiotico). In quei casi l’uso va valutato con specialisti. Per la diarrea acuta comune, questi scenari sono improbabili. In bambini con intolleranza al lattosio o allergie alimentari, controllare gli eccipienti del prodotto (alcuni contengono tracce di latte o soia derivati dalla coltura batterica).
Conclusioni
L’impiego di probiotici nella gastroenterite acuta pediatrica rappresenta un esempio di approccio “microbiologico” alla cura di una malattia tradizionalmente gestita con misure reidratanti. Le evidenze scientifiche, pur non essendo granitiche, indicano che alcuni ceppi probiotici possono offrire benefici modesti ma reali, traducibili grossomodo in un giorno in meno di diarrea e sintomi leggermente attenuati . I ceppi con più solide evidenze (LGG, Saccharomyces boulardii, L. reuteri DSM 17938, ecc.) hanno un buon profilo di sicurezza e, se usati correttamente, raramente causano effetti indesiderati nei bambini . Pertanto, l’uso di questi probiotici come terapia aggiuntiva è ragionevole nella pratica pediatrica: può aiutare alcuni bambini a recuperare prima e, almeno, non nuoce.
Detto ciò, è fondamentale ribadire che i probiotici non sostituiscono le terapie di base. La priorità in ogni gastroenterite acuta rimane prevenire o correggere la disidratazione con soluzioni reidratanti orali (o EV se necessario) , alimentare adeguatamente il bambino e monitorare la sua condizione. I probiotici vanno affiancati a queste misure standard, non usati al loro posto. Inoltre, in caso di gastroenterite batterica in cui sia indicato un antibiotico, questo non va omesso pensando di risolvere solo con i fermenti: l’antibiotico appropriato salva la vita nelle infezioni invasive, mentre il probiotico semmai limita i danni collaterali.
L’uso dei probiotici in acuto dovrebbe essere mirato: è consigliabile impiegare solo prodotti contenenti ceppi provati efficaci (o equivalenti specificati dalle linee guida) , al giusto dosaggio, iniziati precocemente e dati per un numero sufficiente di giorni. L’impiego indiscriminato di “fermenti” qualsiasi, o per periodi troppo brevi, potrebbe spiegare perché a volte in pratica non si osserva alcun beneficio. Invece, quando ben utilizzati, i probiotici di comprovata efficacia possono ridurre la durata della malattia diarroica acuta nei bambini e facilitare un recupero più rapido dello stato di salute intestinale .
D’altra parte, le evidenze più recenti ricordano che non bisogna aspettarsi miracoli: i probiotici non funzionano in tutti i casi e i risultati più rigorosi suggeriscono che, almeno in alcuni contesti, l’effetto potrebbe essere minimo . Il livello di raccomandazione attuale è relativamente debole , proprio perché servono ulteriori studi per identificare meglio quali pazienti traggono giovamento, in quali condizioni e con quali ceppi/dosi ottimali. La ricerca è tuttora in corso: nuovi ceppi, nuovi prodotti (ad esempio simbiotici, combinazioni di probiotici e prebiotici) e migliori metodologie potrebbero in futuro fornire evidenze più solide e ampliare le indicazioni.
In conclusione, per un pediatra o un genitore che si chiede “Vale la pena usare i probiotici in caso di gastroenterite?”, possiamo riassumere così: sì, vale la pena considerarli come aggiunta, soprattutto se si scelgono i ceppi giusti (LGG, S. boulardii, ecc.) e si iniziano presto – ci sono buone probabilità che aiutino il bambino a stare meglio prima. Allo stesso tempo, non sono obbligatori: molti bambini guariscono velocemente anche senza, quindi non c’è da allarmarsi se non si hanno a disposizione. L’importante è gestire bene idratazione e alimentazione; il probiotico, se usato, è quel qualcosa in più che può fare la differenza in positivo. E considerata la sicurezza elevata, provarlo in corso di gastroenterite (sotto consiglio del pediatra) è ragionevole.
Come sempre, le decisioni terapeutiche vanno adattate al singolo paziente: in un lattante molto piccolo o un bambino con condizioni mediche particolari, il pediatra valuterà caso per caso l’impiego di probiotici. Nel complesso, però, i probiotici rappresentano uno strumento di gestione “fisiologica” della diarrea in pediatria , in linea con l’idea moderna di curare sostenendo i processi naturali del corpo (in questo caso il microbiota) piuttosto che sopprimerli. Con le dovute precauzioni e aspettative realistiche, possono contribuire a ridurre la durata e l’intensità della gastroenterite acuta nei bambini, rendendo quel fastidioso episodio un po’ più breve e sopportabile sia per il piccolo paziente che per la famiglia.
Fonti:
• Dargenio V.N., Francavilla R. “Un bel probiotico e passa tutto.” Area Pediatrica 2023;24(2):82-83 .
• Depoorter L., Vandenplas Y. “Probiotics in Pediatrics – A Review and Practical Guide.” Nutrients. 2021;13(7):2176 .
• Szajewska H. et al. (ESPGHAN Working Group). “Probiotics for the Management of Acute Gastroenteritis in Children: An Update.” J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;71(2):261-269 .
• Bezkorovainy A. “Probiotics: Determinants of Survival and Growth in the Gut.” Am J Clin Nutr. 2001;73(2 Suppl):399S-405S .
• Rupa Health – “Do Probiotics Survive Stomach Acid?” (articolo divulgativo con riferimenti scientifici) .
• Linee guida ESPGHAN/ESPID 2014 – Guarino et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014 .
• AGA Clinical Practice Guidelines 2020 – Su GL et al., Gastroenterology 2020 (ruolo dei probiotici in gastroenterite) .
• Nutrienti e Supplementi – “Probiotici e terapia antibiotica nei bambini: pratiche dei pediatri italiani.” 2025 .
• Ospedale Bambino Gesù – “Gastroenterite nel bambino” (scheda informativa) .
• Frontiers in Microbiology – Wendel U. “Assessing Viability and Stress Tolerance of Probiotics – A Review.” 2022 .